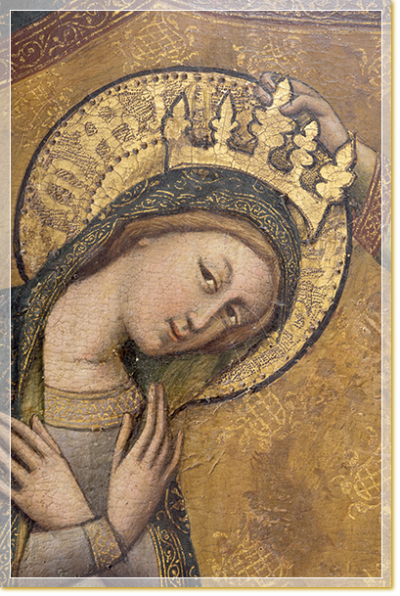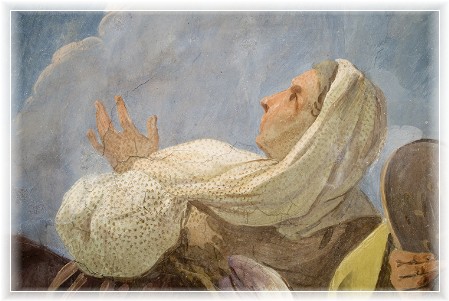La Benedetta tra le Donne e alcune figure femminili dell'Antico Testamento
MIRIAM la sorella di Mosè e Aronne.
La
scena presenta tre rilevanti figure, questa volta unite dal vincolo della
parentela e dalla contemporaneità degli eventi narrati. In un unico spazio. Assisi
sopra nuvole spumeggianti, al centro è raffigurato Mosè con in mano le
tavole della legge. Alla sua sinistra, in posizione arretrata, un sacerdote identificabile con il fratello
Aronne e alla sua
destra una figura femminile volta di profilo,
lo sguardo levato verso l’alto, quasi disinteressata agli altri due. Credo vada identificata con Miriam la sorella
di Mosè.
Maria, la sorella
di Mosè e Aronne, profetessa anch’essa, ha un ruolo importante per la vita stessa di Mosè.
È la giovane che assiste nascosta al
ritrovamento di Mosè da parte della principessa egizia.
Suggerisce alla principessa di cercare una donna
per allattarlo e lo riporta così alla madre che lo allatterà per tre mesi. In qualche modo dona la vita a Mosè, è
artefice della sua salvezza consentendogli non solo di vivere,
ma di nutrirsi del latte materno.
Veglia sulla buona riuscita dell’impresa tentata dalla madre
(altra coraggiosissima donna che per dare la vita al figlio rischia anche di
ucciderlo), vigila nascosta tra i giunchi, interviene al momento opportuno. È Presenza discreta
e determinante[1].
La parola essenziale con la quale incontriamo
Miriam è essa stessa pregna di valori: “La
sorella del Bambino si pose ad osservare da lontano
che cosa gli sarebbe accaduto” con queste parole la Scrittura presenta
Miriam che vigila sulle rive del Nilo, silenziosa e attenta agli eventi, pronta
nell’intervenire. Cosa che farà al momento opportuno.
Questi dettagli
pongono ancora più in risalto
la Fede di Miriam che osserva
da lontano quando le sue profezie sembrano
svanire e in molti le rinfacciano le sue false predizioni.
Lei osserva fiduciosa.
La stessa Fede sembra accompagnare le donne di Galilea
e la Madre di Gesù la quale crede alla rivelazione
di un grande evento che si realizzerà attraverso di lei e lo vede poi svanire,
distrutto dagli eventi storici ove al posto del Regno c’è la croce. Eppure, resta ferma sotto la croce come
Miriam che osserva da lontano mentre il fratello sta per
essere inghiottito dalle
acque del Nilo.
Miriam e Maria:
senza la prima non ci sarebbe
stato Mosè, senza Maria non sarebbe
stata possibile l’incarnazione.
La nostra raffigurazione evidenzia una molteplicità di significazioni che portano a capovolgere la preminenza dei ruoli.
Obiettivamente Mosè giganteggia al centro della scena e Aronne, voce di Mosè, esercita il suo ministero, rivestito degli abiti sacerdotali. Miriam è apparentemente figura marginale
rispetto a Mosè, l’uomo che tiene in mano la legge. Miriam però rappresenta
colei che ha saputo guardare da lontano, che è andata oltre la legge e seguendo l’intuizione del suo cuore ha salvato
Mosè dalle acque e con questo suo gesto ha
reso possibile la salvezza di un popolo. Miriam, nel suo splendido isolamento, sembra
disinteressata alla “legge” incisa nella pietra. Vive assorta,
guarda lontano, e il suo sguardo
incrocia quello dell’Assunta.
Nel nostro affresco
è possibile evidenziare quel ruolo che di fatto la scrittura le ha sempre
dato e che altrettante volte è stato relegato all’ombra degli eventi che videro
protagonisti i due fratelli.
[1]
Maria compare altre volte nella Scrittura. Ancora in Esodo (15,20) dopo che il mare si è richiuso
sull’esercito del faraone
“Maria, la profetessa, sorella di Aronne” prese il timpano e assieme alle donne con altri timpani
cantarono e danzarono.
(ancora un ruolo propositivo. Il ringraziamento, il canto di
ringraziamento, scaturisce
da una donna. La prima a ringraziare per il dono della vita.) in Numeri 12 è narrata la
contestazione
di Maria e Aronne verso la scelta di
Mosè di sposare una donna Etiope e la punizione di Maria poi “graziata” per
intercessione Mosè. In Numeri 26,59
è riportata la genealogia della famiglia. La madre, nata in Egitto,
generò ad Amram “Aronne, Mosè e Maria loro
sorella”
Abigail, La Prudente E Saggia.
Nel sesto riquadro
incontriamo Davide facilmente identificabile per lo strumento a corde con cui sembra intonare i suoi Salmi.
Alla sua destra un uomo con gli occhi volti verso
il cielo: è Isaia. Lo riconosciamo per l’asta che tiene tra le mani che, vista
da vicino, si rivela dentata. È la sega di legno con la quale, stando ad un’antica tradizione, il profeta fu martirizzato da Manasse117. A sinistra di Davide una figura
femminile seduta su un trono di
nuvole che l’avvolgono. Tiene sulle ginocchia
un vassoio colmo di quelli che possono essere dei pani. Credo non ci si
possa sbagliare identificandola con Abigail, moglie di Nabal.
Ancora una donna protagonista. Abigail che impedisce
ad un grande re di farsi giustizia con le proprie mani. Davide non è
ancora il re. Provocato dal marito di Abigail, il malvagio Na- bal,
marcia contro di lui con i suoi uomini. Abigail
viene a conoscenza del prossimo
scontro e decide d’intercedere
presso Davide, rinunciando a parlarne al marito. Corre incontro a Da-
vide, si prostra con la faccia davanti
a lui, offre i suoi cibi per i suoi uomini e impedisce lo spargimento di sangue ricordando a Davide che nel giorno in cui sarà fatto re, non “sia d’angoscia o di rimorso al tuo cuore questa cosa: l’aver versato invano il sangue e l’aver
fatto giustiza con la tua mano”.
(1, Samuele 25,31).
La storia è ancora una volta nelle mani di una donna. Con la sua saggezza
e capacità operativa
(evitando impossibili discussioni con il marito, ma agendo) aiuta Davide
a non farsi giustizia
da solo, a non macchiarsi di sangue.
DEBORA, LA PROFETESSA.
Debora, un’altra donna da
collegare a Giaele, raffigurata lì accanto, ma separata a sottolineare la
centralità avuta anche verso Giaele.
Debora ordina a Barak di preparare l’esercito per attaccare Sisara e i suoi novecento carri da guerra.
Barak accetta solo se la profetessa sarà al suo fianco. Debora promette, ma avvisa anche che in questo caso Sisara
sarà messo nelle mani di una donna (Giudici, 4, 9 – 10). La donna sarà Giaele nella cui tenda Sisara
troverà rifugio e poi anche la morte, come vedremo presentando Giaele raffigurata assieme a Giaele e Ester. La separazione di Debora da Giaele
consente di accentuare la centralità di questa Madre
d’Israele. Debora,
Giudice e Profetessa, sedeva sotto la palma
che è poi l’elemento iconografico che la contraddistingue. Debora è l’esempio di donna forte che ridona dignità ad Israele dopo il suo arrivo
nella terra promessa.
GIAELE (guerriera e politica?).
Giaele, ricalca un episodio simile
a quello di Giuditta,
descritto nel libro dei Giudici e
coordinato dalla profetessa Debora che esaminiamo a parte.
Sisara, agli ordini del re
di Canaan, muove contro Israele con un potente esercito. Debora, ispirata dal Signore, chiama
Barak e lo mette
a capo dell’esercito che marcerà
contro Sisara. Barak tentenna
e accetta di guidare l’esercito solo se Debora lo accompagnerà.
Debora accetta, ma avvisa
Barak che il Signore metterà “Sisara nelle mani di una donna”. Barak sconfigge
l’esercito di Sisara e i suoi carri da guerra, ma Sisara fugge e trova rifugio sotto la tenta di Giaele, il cui sposo era un suo alleato.
Giaele gli offre ospitalità, ma poi mentre lui dorme, prese un picchetto della tenda, prese in mano il martello, venne pian piano a lui e gli conficcò il picchetto nella tempia, fino a farlo penetrare in terra. (Giudici 4,21).
GIUDITTA.
Ad essa l’onore di uccidere Oloferne,
il potente generale
di Nabuconodosor, e salvare il suo popolo che, ormai
disperato, aveva posto un termine all’Onnipotente: ancora cinque giorni e poi la resa a Oloferne. Giuditta, mostrandosi sapiente, richiama
gli anziani rilevando che non è in loro potere
mettere alla prova il Signore. Mostrando un’assoluta fiducia
nel Signore aspetta
la salvezza che viene da lui che è anche padrone di non concederla. Usa infine il poco tempo
“concesso” dagli uomini a Dio perché intervenga e salvi Israele dall’invasore,
per mettere a punto un suo piano
operativo per sconfiggere il potente
esercito di Oloferne. Giuditta, bella d’aspetto
e molto avvenente
nella persona (Giuditta 8,17). La bellezza è intesa come la rifrazione esteriore di una bellezza più intima. Essa incarna
anche la Sapienza,
conosce e osserva la legge mosaica, dà una giusta
interpretazione dei castighi: è a fine di correzione che il Signore castiga coloro che gli stanno
vicino.
Una convinzione profonda risiede
in Giuditta: essa sa
che la salvezza del popolo dipende dalla fedeltà assoluta alla legge del
Signore.
Poi la preghiera prima dell’azione. Giuditta è strumento di Dio come Mosè.
Come Miriam che, dopo il l’attraversamento
del mar rosso, eleva un canto al Signore, anche Giuditta, quasi novella Miriam,
dopo l’impresa prende in mano degli strumenti musicali e le distribuì alle
donne che erano con lei.
Giuditta, pur essendo una donna
ricca, è una vedova, ai margini della società
del tempo. La sua
debolezza, ricca solo di Dio, la rende capace di sconfiggere il potere.
ESTER. (mediazione politica
preparata dalla preghiera)
Ester, la terza donna
della composizione, lavorerà
anch’essa per la salvezza del Popolo, ma lo farà impetrando la grazia dal suo
Re facendo emergere le prove di un
raggiro perpetrato da cattivi consiglieri a danno del Re e del popolo ebreo. Anch’essa
prima dell’azione si affida
alla preghiera per trovare
in essa il giusto equilibrio e poter così presentare
al meglio la causa al re. Prima dell’azione la purificazione, quasi a sottolineare che l’azione è conseguenza di un cammino di fede.
Tanto in Giuditta che in Ester, e ancora
con Giaele, la vita di Israele dipende da una donna. Giuditta e Gialele assolvono il compito
attraverso un’azione cruenta, Ester attraverso la preghiera e, in quest’atto, è
stata vista una possibile prefigurazione di Maria. Al di là di queste interpretazioni resta fondamentale il ruolo riservato
alla donna che, in vari modi dona la vita al suo
popolo. Ora salvandolo dai nemici esterni, tal altra aiutando la vita dei suoi figli migliori.
Achior (?)
Il personaggio,
apparentemente marginale nella
storia di Giuditta, negli anni in cui Milani dipingeva la cupola godeva di un indiscusso prestigio grazie ad
un oratorio di Pietro Metastasio musicato nel 1771 anche
da Mozart (Betulla liberata),
incentrato sulla storia di Giuditta e Oloferne. Oloferne non compare,
ma i dettagli della decollazione sono raccontati da Giuditta.
Deuteragonista della storia
è Achior che, dopo l’impresa di Giuditta, si converte
e inneggiando al Signore canta l’aria “Te solo adoro mente infinita,
fonte di vita”.
principe Ammonita Achior, alleato
di Oloferne, che su richiesta del condottiero,
spiega che il popolo di Israele, se si è mantenuto fedele
ai principi del suo Dio, è
praticamente invincibi- le. Oloferne, sdegnato, lo caccia
e lo mette nelle mani di Israele.
Interrogato dagli israeliti
espone le sue vicende
e il suo racconto permetterà a Giuditta di elaborare la sua strategia per entrare nella tenda di Oloferne. Davanti
alla vittoria di Giuditta che porta con se la testa di Oloferne,
Achior si gettò ai piedi di Giuditta pieno di riverenza per la sua persona.
RACHELE CON BENIAMINO.
Alla destra di Giacobbe
un’altra figura maschile
dall’aspetto giovanile e alla
sua sinistra due donne e un bambino. Potrebbero essere le due sorelle
e sue mogli, Lia e Rachele.
Tra
queste primeggia la prima
figura che tiene a se un fan ciullo in piedi. Dovrebbe essere
Rachele con Beniamino, il fanciullo
per la cui nascita sacrifica la propria vita. Il ragazzo alla destra di Giacobbe, a
questo punto, non può che essere il primo figlio di Rachele: Giuseppe. Se questa è la
lettura è evidente che la rappresentazione, sia pure
introdotta da Giacobbe, ruota attorno a Rachele, mentre Lia, pure madre di molti
figli di Giacobbe, sfuma tra le nuvole. Rachele che è vista da Geremia
quale madre di tutto il popolo
di Israele112, è donna
amata da Giacobbe. Un amo- re che lo costringe a lavorare quattordici anni per il suo ri-
scatto e, a differenza
dei tan- ti matrimoni
“contrattati”, è storia d’amore tra due giovani che si incontrano e si amano.
Ma Rachele è sterile, a differenza di Lia, prima moglie di Giacobbe,
avuta con l’inganno, che gli dona molti figli. E Rachele vive nell’attesa del dono della
maternità e alla fine sarà madre di Giuseppe e poi muore partorendo il secondo
figlio: Beniamino. Una “maternità dolorosa”
simile a quella di Maria, l’Assunta. Così come simile a Maria è la sua
riconosciuta maternità del popolo d’Israele, ricordata da Geremia. Anche quella della Vergine sarà maternità non solo del Cristo,
ma di tutta la Chiesa.
Per Lia la maternità
è naturale, per Rachele è un dono cercato
e faticoso. Il dipinto, se è giusta la lettura proposta, è quasi una visione
che mette in risalto la maternità di Rachele, ancora
“viva” con stretto
a sé il vispo Beniamino. Nuovamente l’attenzione si sposta dal personaggio in primo piano ad una donna
che introduce il mistero
della vita. Uno schema che tornerà a rivivere nel riquadro
successivo con raffigurato il “sacrificio di
Isacco”.
RUT, la straniera.
Noè, Giosuè e Rut. La storia
biblica comincia dall’arca, primo simbolo
dell’alleanza tra Dio e gli uomini. Noè al centro
e in alto; alla sua sinistra un personaggio in armi; alla sua destra
una donna distesa sulle nubi che poggia il fianco su dei covoni di grano. In basso al centro
un angelo che tiene in alto con la mano sinistra la falce
e poggia la destra su delle spighe di grano.
Chiara l’immagine di Noé accanto all’arca su un alto monte nel momento in cui la colomba
torna ad esso con il ramoscello d’ulivo. Intorno al tema
dell’arca dell’alleanza, ora figurata in Noè si giustifica la figura dell’uomo in armi in basso a destra di chi
guarda. Sullo scudo è raffigurato un sole. Possibile
iconografia per Giosué
il condottiero al quale Dio permise di rallentare
il cammino del sole con la sua preghiera88. Questo
il segno, ma la sua figura,
in questo caso, è credo simbolo dell’uomo che fa passare l’arca dell’alleanza nella terra promessa. Ancora un riferimento al popolo in cammino mentre
le acque del Giordano si
aprono per consentire all’arca di attraversare il fiume. Dall’arca di Noè all’arca del Signore. Dunque, il possibile legame è nell’arca
dell’alleanza, prefigurazione della nuova alleanza
per raggiungere la quale occorrerà
la fides di Maria, il sapersi
fidare di Dio. In questa prospettiva trova giustificazione e diventa il punto di riferimento innovativo la figura
femminile sulla sinistra. Giosuè
è il condottiero fedele alla voce del Signore che gli parla, Dall’altro lato la
figura femminile che poggia sopra le messi mature può essere identificata con Rut. La
donna che non parla con il
Signore, ma si fida del Signore e la cui fedeltà è vissuta in maniera
operosa. La sua fiducia viene
ricompensata.
La sua storia è quella di una sposa che vive con
il marito lontana da Israele. Perduto il marito resta con la madre dello sposo condividendone
la sorte e affidandosi al Signore. Torna
così a casa della suocera, in Israele e qui acquista grazia agli occhi di Dio e
è ben accolta da un suo lontano parente che la incontra mentre spigolava nei
campi dietro ai mietitori. Torna a casa piena delle messi donate dal padrone che poi la sposa.
Essa mostra come il Signore volge il suo sguardo anche verso lo straniero accogliendolo in seno al suo popolo. La prima scena attraverso tre personaggi identificati per la loro iconografia,
racconta il passaggio dalla fedeltà
di un popolo alla fedeltà del singolo. Dalle guerre spesso cruente e sanguinarie
di Giosuè, alla delicata storia di una donna che si fida di Dio, posta quale
prosecuzione dell’alleanza. La prima arca, l’arca dell’alleanza traghettata da Giosuè, la Fiducia di chi ha creduto senza vedere e si è convertita grazie alla testimonianza della suocera e del marito. Un
salto di qualità: dall’osservanza della legge
che porta
in cambio la vittoria sui nemici,
alla Fiducia nel Signore
che porta la pace nel cuore
di Rut. Con un procedimento che sperimenteremo altre
volte in questo ciclo, il compimento della simbolica narrazione ha per protagonista una donna. Apparentemente un personaggio meno importante rispetto ai giganti come Noè e Giosuè,
eppure in essa trova compimento il cammino
della storia.
Al centro l’angelo che
con la falce e le spighe riprende e
accompagna il lavoro di Rut,
sottolinea ulteriormente la centralità della figura femminile.
REBECCA E SARA.
Abramo e Isacco,
in primo piano
e con gli occhi volti
al cielo, stupiti e grati, sono raffigurati nel momento
in cui ascoltano la voce dell’angelo che sospende il sacrificio di Isacco richiesto da Dio. Non c’è ombra di dramma e lo stesso
agnello sembra
tranquillamente accovacciato su un fuoco che non brucia. Ma la scena si arricchisce di due figure femminili, in secondo piano, eppure portanti nell’economia della raffigurazione.
Proviamo ad identificare la prima, con in mano un bastone, segno di comando, con Sara, moglie di
Abramo. Donna che con Abramo condivide tutta la vita e nella tarda età, quando a Sara era cessato ciò che avviene regolarmente alle donne114 per intervento di Dio avrà da Abramo
il figlio Isacco. Sara non riesce a credere alla
promessa di Dio. Il miracolo si compie non contro la volontà dell’uomo, ma contro ogni speranza umana. I tre uomini che appaiono davanti alla tenda di Abramo nell’ora
più calda del giorno, riconosciuti da Abramo come messaggeri
di Dio, “annunciano” la prossima nascita di un figlio. In Sara e nello
stesso Abramo c’è diffidenza e incredulità, non c’è il fiat di Maria. Ma Dio mostra pazienza e
conferma la promessa. L’altra donna è quasi certamente Rebecca, la sposa di Isacco. Di
fatto quando Isacco
sposerà Rebecca Sara è già morta. Rebecca
che in tre passaggi successivi del testo biblico
è presentata come Vergine, sposa e madre. Anche Rebecca è sterile, come Sara, e anch’essa
ottiene da Dio il dono della maternità. Rebecca avrà due figli Esaù e Giacobbe. È nota la storia tra Esaù e Giacobbe per la primogenitura e
il ruolo avuto da Rebecca nel favorire
Giacobbe, raffigurato nel precedente riquadro che rincontrerà poi Esaù
ricomponendo l’unità della famiglia. Essa rappresenta la continuità
femminile. Non a caso Isacco introdusse Rebecca
nella tenda che era stata di sua madre Sara e Isacco
trovò conforto dopo la morte della madre. Questa continuità è ben espressa dall’incontro – mai avvenuto -
tra le due donne. Come se fosse Sara a presentare il figlio a Rebecca indicandolo con la mano e rendendo
così visibile un legame già rilevato dal Testo Sacro quando Isacco, introducendo Rebecca
nella tenda che era stata di Sara,
di fatto la insedia al suo posto.
Due donne trasmettono la vita
in modo straordinario per intervento
di Dio che agisce sulla loro sterilità
e, nel caso di Sara, con un “annuncio” che ha fatto ricordare quello testimoniato nel vangelo
di Luca. Si fronteggiano due rappresentazioni che incarnano
altrettanti valori: da un lato l’obbedienza di Abramo e dall’altro il dono di Dio a Sara e
Rebecca. Sara raffigurata con in mano quello che sembra il bastone del comando che sarà ceduto a Rebecca
nel momento in cui, rallegrando Isacco,
prenderà il posto della
Madre occupandone la tenda.